La lingua è la sua ossessione ma la lingua è lui stesso. Deve continuare ad avere commercio con le parole, facendole andare al galoppo. La fascinazione di leggere un individuo come un libro aperto è il motivo dell’interesse per Lo sbilico di Alcide Pierantozzi (Einaudi, 2025), del quale si rimane innanzitutto colpiti per l’estremo sperimentalismo linguistico. La storia reale è quella incistata nel autore, che soffre di psicosi e fa di tutto per apparire simile ai comportamento dei non neuropatici.
Ho letto il romanzo perché sono molto attento ai nuovi talenti, sebbene per Pierantozzi sia questo il sesto volume. Del suo stare nel mondo non ha remore e il romanzo è pieno di descrizione della sua malattia, delle allucinazioni delle
“piccole contrarietà di ogni giorno, piccole carenze nella struttura sociale, piccole truffe e scorrettezze quotidiane in seno alle quali è cresciuta la mia malattia”.
Il lettore sa che la distanza tra l’opera e la persona è annullato e che in un certo senso la solitudine del suo stare nel mondo eleva Alcide non a una specie di “fenomeno” ma lo fa un uomo che usa la scrittura come scudo contro l’orrore che lo calamita
Inceppare
Del romanzo Lo sbilico mantengo il rispetto per chi solo ha “il diritto di essere soccorso dai sani, ma anche il dovere di inceppare ogni giorno il mondo per metterlo in discussione ai loro occhi”. E da questo punto di vista interessa la lingua, orientata non al riconoscimento dell’esistente disturbo psichiatrico, bensì alla trasmissione di percezioni nuove, estranee alla più parte dei lettori.
La vicenda, invece, è indigeribile – e proprio per questo aggressiva -, perché è scritta in presa diretta dalla vita di Pierantozzi che fa udire la sua voce in mezzo al clamore dei luoghi comuni, come quello che unisce genio e pazzia. La trama è un coacervo di riflessioni frammentarie che seguono il difficile equilibrio della sua mente, di formulazioni spiazzanti che sembrano voler concorrere con le sperimentazioni verbali, verso parole oscene.
Perché il protagonista riceve da chi lo circonda un messaggio che sente sempre a lui diretto, nella continua perplessità che la parola sorga sempre dal lato dell’altro. La sua è una scrittura che amo e ho scorso con attenzione non tanto per l’ostensione accademica di elogi sull’uso della lingua e l’effetto straniante della vicenda, che appaiono ormai inestirpabili dalle cortesie della nuova critica non letteraria ma editoriale. E nella recensione al romanzo cercherò di dirvi come e perché.
Farsi sentire
Da una parte, Pierantozzi annota e investiga le forme linguistiche, in una prospettiva anche diacronica e transnazionale, al fine di individuarne le leggi interne; dall’altra la sua fedeltà alla lettera, gli crea nella quotidianità non pochi problemi: la cura nel trascrivere il più esattamente possibile le parole udite, rispettando le espressioni gergali e dialettali; la punteggiatura (il dire ha delle pause, come riprodurle?).
“Ogni cosa che dico è immensurabile per i calibri del mio cervello. Al suo interno c’è la solita zona illegittima, come mi piace chiamarla, dove sono conservate le parole peggiori, le volgarità sessuali e le blasfemie più fantasiose. Ho anche un lessicario di parolacce e bestemmie creative, che vado riempiendo da anni (Sade, Pasolini, Busi, Genet, Divert)”.
Quando ha iniziato a sentire le prime voci allucinate, pensa a una “specie di animale subnotturno che era venuto a rombarmi in testa”.
“Gli psicofarmaci fanno da tappi antirumore per me, e da isolante per lui [l’amico angelo]”.
Vivere sulla lingua
Lo sbilico è per me non tanto la definizione coraggiosa di come si viva con ricette, prescrizioni di analisi, appuntamenti psichiatrici, diagnosi, scatti d’ira, specie contro la madre malata. Lo sbilico èla ricerca incessante di una lingua per dirsi. Una nuova lingua, insidiosa perché sembra quella che anche noi usiamo (essendo fatta delle stesse parole) ma fuori dal nostro discorso comune. Perché, spesso capita a Pierantozzzi
“il diavoletto che vive sulla mia lingua ha parlato tutto il giorno da dentro un’allucinazione”
anche quando si allena febbrilmente in palestra per dare una consistenza a un corpo che la parola stessa riduce in frammenti.
Registrare
In tedesco Eintrangung significa ‘iscrizione’, ‘registro’ e il verbo eintrangen significa ‘registrare, trascrivere, annotare’ in un libro di registro o libro contabile. È un vocabolo interessante che ci permette di definire meglio la posizione in cui mi sono posto, ossia come “segretario”, come colui che ha trascritto degli enunciati di Alcide perché la sua eresia, cioè la sua personalità così straordinaria e dolorosa, che anche lui percepisce di non poter dire a tutti, venga accolta nel suo modo preciso di metterla in forma.
Ed è allora la voce inquietante di un essere imprevedibile che viene a imporsi, quella che l’immaginario attribuisce a chi occupa una posizione di linguaggio, questo luogo Altro che può essere solo un luogo vuoto affinché il soggetto vi trovi il suo habitat. E anch’io con Alcide Pierantozzi
“Tutto quello che voglio è che questa storia venga annusata, leccata, triturata, ingoiata, digerita in uovo e poi in bozzolo. E che infine diventi una farfalla di carta”.
Il lettore deve aspettare fino in fondo perché i fogli – secondo il desiderio dell’Autore – si siano consumati e che “nella sciara fra gli insetti si formi una farfalla”. La mia è riposta in una scatola di sicurezza e spero rinata attraverso queste parole – Carlo Albarello






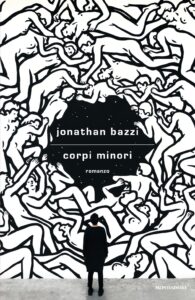
6 risposte
La lettura di questo libro per me è stata esaltante e faticosa, controversa e insofferente, indigeribile come dice bene Carlo, forse perché non c’è velo, o corteccia, o piuma. È affascinante l’uso e la considerazione del ruolo della lingua, ma l’immaginazione resta frustrata e se ne esce “asciutti e secchi”, proprio come una farfallina della carta.
L’ho letto appena uscito in libreria e c’è voluto tempo per entrare nella storia. Sono contento che anche tu lo consideri un romanzo imprescindibile.
Ma che bravo 🤩
Grazie! Il libro merita una lettura attenta e un resoconto adeguato. Spero che il romanzo ti piacerà.
Il primo punto di ingresso che ho trovato nella lettura de “Lo sbilico” di Alcide Pierantozzi è una frase nelle prime pagine: “Un nevischio ventato che imbrattava il bianco monacale attorno al lago”. Lampo di una visione improvvisa di un paesaggio invernale a cui l’invenzione della parola ventato e il battere del ritmo sulla lettera t (ventato, imbrattava, attorno) spalanca uno spazio virtuale dove si proietta la consistenza di un’immagine in presa diretta, di un miraggio.
Un nevischio che irrompe e soffia via la compostezza dell’immagine. Un nevischio che batte inesorabile in ogni momento della vita di Alcide Pierantozzi, in ogni sua pagina. E non è facile leggerlo, ascoltarlo, ascoltarlo in silenzio, fino “in fondo all’erta”, di una risalita, che per lui è da rifare ogni giorno, ogni momento del giorno come per tutti quelli che si sentono “abusivi nel mondo dei sani e dei normali”.
Ho dovuto chiudere, a più riprese, questo libro di Alcide Pierantozzi, e ritrovare intorno a me qualcosa di diversamente tangibile. Ricrearmi uno spazio e fargli posto. Ma anche non ho potuto accantonarlo, e per leggerlo, ho dovuto accettare di farmi trascinare nei meandri del suo particolare rapporto con il linguaggio: “Sono sempre in cerca di parole assolute, che mettano il guinzaglio ai pensieri, che facciano un po’ d’ordine nella scompagine che ho in testa.”
Una ricerca infinita, per lui, di “parole assolute” con cui potersi dire, con cui frenare, arginare, imbrigliare, l’incessante fluire dei pensieri, delle sensazioni, delle dispercezioni, delle allucinazioni.
Eppure, quella di Alcide Pierantozzi, è una scrittura che può essere letta, anche là dove è più insostenibile. Una scrittura che vuole essere letta e che ha il coraggio dello svelamento della sofferenza che comporta essere presi nella malattia psichica, dello sbilico. Una scrittura dove lo sbilico coesiste con una creazione poetica che ha l’incanto del miraggio. Come, ad esempio, quando ci parla del suo orrore del buio della notte e di come lo tratta attraverso la scrittura: accostando parole, riga dopo riga, allontanandosene, fino ad arrivare a intrappolarlo, almeno per il tempo della scrittura, nel gioco della lingua: “Anche in montagna il buio scarroccia secondo le variazioni di luce del fondovalle, e sulle rocce è saponoso di luna.” Fino ad arrivare al piacere di pronunciare le parole, anche noi, forse insieme all’Autore che le ha inventate, un piacere saponoso di luna.
Grazie per la lettura condivisa.